Il problema
dell’empatia nella relazione di cura
di Giusi Venuti*
Se, riecheggiando Hegel, la filosofia si qualifica
come “il proprio tempo appreso con il pensiero”, non
deve allora apparire affatto strano che un non-medico
si interroghi su quella crisi che da decenni stringe
in una morsa il sapere e l’agire del medico nonostante
il raddoppio delle aspettative di vita ed il
miglioramento dello stato di salute della popolazione
generale.
Allora perché un disagio si insinua come un tarlo,
perché l’impressione che il pensare sia sempre
fuori luogo? Se, da una parte, si potrebbe
rispondere che è proprio il disagio del non sentirsi
mai a casa propria a costituire l’anima della ricerca
autentica, dall’altra non si può, tuttavia, nascondere
che esso nasca dalla consapevolezza di non poter dire
nulla di veramente nuovo in merito alla ormai
vexata quaestio. Nel desiderio, totalmente
umano, di apportare nuovi argomenti, quel disagio
assume allora una veste talmente subdola da far
affiorare, per qualche istante, nella mente dello
studioso il pensiero che, data l’impossibilità di dire
il nuovo, sia meglio non dire niente.
Ma poi, a ben rifletterci, perché pretendere di dire
qualcosa di nuovo?
Caratteristica del pensare non è, forse, quella di
ritornare su vecchi problemi, non è, forse, quella di
andare sempre all’origine nel tentativo di
re-interpretare e di decodificare le cause, o la
causa, di tale crisi?
Solo se accettiamo questa impostazione possiamo
comprendere ciò che David Clouser, primo professore di
bioetica, afferma nel momento in cui dice che gli
eticisti non sono dei riformatori perchè il loro
compito è quello di portare alla luce i conflitti
sottesi ai principi etici.
Bisogna, allora, procedere alla profanazione con la
consapevolezza che al di là di ogni legittimazione che
derivi da un sapere, da una professione o dalla natura
interdisciplinare della bioetica, è necessario che
ciascuno si assuma la responsabilità di tali
interrogativi.
L’essere paziente infatti non è solo un’identità e un
ruolo che transitoriamente indossiamo, ma è più a
fondo una possibilità che appartiene alla dimensione
costitutiva del nostro esserci, in quanto mortali e
per ciò stesso vulnerabili.
É in questa nuova prospettiva che quel disagio, da
subdolo ingannatore, si fa amico fidato, amico che
sorveglia il nostro andare e che lo mantiene retto
dinanzi alle troppo facili prese di posizione.
***
Perché, in questo preciso momento storico, la scienza
medica appare più che mai incapace di rapportarsi al
proprio oggetto di studio: il paziente?
É colpa dei medici che dovrebbero imparare a vedere in
quell’oggetto qualcosa di più che un corpo da guarire,
o è colpa dei pazienti che, eccessivamente - e spesso
malamente - informati, pretendono di ridurre l’opera
del medico a mera prestazione funzionale alle proprie
esigenze?
Buona parte degli studiosi fa propendere la bilancia
tutta da una parte: il malessere sarebbe, così,
interamente imputabile alla scienza medica.
La, forse eccessiva, tecnicizzazione, i tempi sempre
più ridotti, la burocrazia asfissiante, hanno
sicuramente contribuito a minare questa delicata
relazione nelle sue fondamenta, tanto dall’invitarci a
pensare a nuovi paradigmi alla luce dei quali
rimodulare la comunicazione interrotta. Ma oltre a
queste cause, che definirei esterne, ritengo che il
motivo di tale crisi risieda nell’intima natura dello
stare in relazione in quanto tale.
Come ogni altro essere umano, infatti, il medico è
sempre posto all’incrocio tra autentico aver
cura ed inautentico prendersi cura, a differenza di
qualunque altro essere umano egli ha, però, in questa
situazione un potere innegabile perché strutturale,
egli si trova di fronte ad una persona che,
contestualmente, è priva di potere. Nella seduzione
che viene dalla manipolabilità della vulnerabilità, il
paziente corre allora il serio rischio di essere
ridotto ad oggetto.
Come uscire dall’impasse?
Come considerare l’altro nella sua alterità,
come ri-conoscerlo realmente come soggetto e non come
mero oggetto? Come rispettarlo?
Credo che sia il caso di andare oltre le indagini
fenomenologiche di stampo husserliano intorno al tema
del corpo-proprio perché ho l’impressione che
esse non costituiscano altro che un’aggiunta
filosofica al problema in questione.
Io non credo infatti che la situazione di crisi in
cui, da sempre, medico e paziente si trovano possa
essere davvero risolta semplicemente ammaestrando i
medici sullo specifico del loro oggetto di
studio e auspicando il passaggio dal modello
biomeccanico a quello biopscicosociale. Non credo che
l’inserimento, nel corso di studi di medicina, delle
medical humanities in quanto tali possa,
davvero, dare un’altra impronta al sapere e all’agire
del medico.
Le più recenti indagini si muovono, invece, in tal
senso.
Quello che ci dicono è che la scienza medica deve
finalmente imparare a parlare non di corpo, ma di
corporeità e che i medici devono abbandonare il
paternalismo, perché irrispettoso ed auto-centrato,
abbandonare il concetto di autonomia del paziente
perché indifferente ai bisogni reali, per assumere un
atteggiamento empatico,
l’unico che, centrando l’attenzione sul vulnerabile,
getta un ponte tra il mondo del medico e quello del
paziente. Ancora di più, sembra che proprio l’empatia
debba essere pensata come il fondamento del modello di
medicina biopsicosociale.
In questo senso l’empatia viene definita come l’atto
del comprendere, dell’essere consapevole dei
sentimenti, delle esperienze, dei pensieri dell’altro.
Ora, quello che mi lascia perplessa è che la maggior
parte di questi studiosi usa indistintamente i
termini: empatia, simpatia e compassione come se
avessero tutti lo stesso significato, quale quello di
attenzione, immedesimazione e compartecipazione con le
sofferenze dell’altro.
D’altra parte «questa» empatia viene presentata come
un nuovo paradigma, in cui scienza ed umanismo
interagiscono, da seguire e da sostituire a quelli
inadeguati ed insoddisfacenti del passato,
come se la comprensione empatica, o la
compassione, fosse veramente la panacea di tutti i
mali, primo fra tutti la crisi in cui versa la
medicina odierna.
In questo senso non è raro trovare degli schemi, come
quello che sto per illustrare, che hanno lo scopo di
esemplificare, anche troppo a mio avviso, la
situazione che sto trattando.
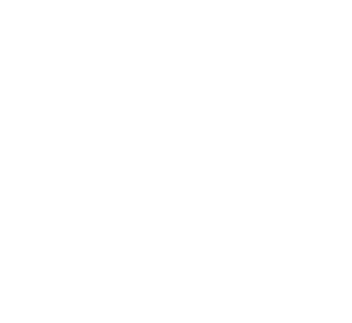
I medici, fortemente convinti della veridicità dello
schema sopraindicato, addestrano i giovani
studenti all’empatia attraverso i giochi di ruolo.
Durante le lezioni, vengono, infatti, invitati ad
indossare i panni del paziente, in modo che
possano rendersi conto di cosa voglia dire stare
dall’altra parte.
L’empatia viene allora presentata come la
caratteristica essenziale del medico che voglia dirsi
virtuoso, del medico che voglia cioè agire onestamente
secondo i precetti di Ippocrate e che non è neanche
sfiorato dall’idea di servirsi in modo inappropriato
del proprio potere.
Per essere un buon medico bisogna dunque afferrare (grasp)
e comprendere
l’esperienza dell’altro come se fosse la propria.
In questi termini l’empatia viene definita come un
coinvolgimento soggettivo che ha lo scopo di
entrare nel mondo dell’altro e di condividerne le
sofferenze.
Entrare nel mondo dell’altro e comprendere l’incidenza
che la malattia ha sul corpo e sul mondo del paziente
significa, secondo buona parte degli studiosi di
Medical Humanities, diventare abili
nell’utilizzare tutti i dati della narrazione
al fine non solo di una corretta diagnosi, ma anche
della liberazione della medicina dal riduzionismo
metodologico.
L’empatia sembra così divenire una tecnica, chi la
utilizza obbedisce ai precetti di Ippocrate e si
guadagna la benevolenza del paziente.
Il metodo oggettivo, ed oggettivizzante, secondo cui i
pazienti non vanno “ascoltati”, ma “auscultati”, viene
ora messo da parte a favore del metodo basato
sull’intervista medica.
L’empatia, quale canone dell’intervista, assume la
veste di guida. Addestrarsi all’empatia significa
allora diventare abili nell’ottenere dei dati umani in
modo più sistematico.
Quindi, intendendo il dialogo come tecnica,
l’intervista trasforma la relazione in strumento e
mezzo per interagire e scambiare informazioni con il
paziente.
Il medico indossa la veste dell’empatia per ottenere
un determinato risultato. Che ne è dell’incontro
clinico? Che ne è della domanda di aiuto? Se ciò a cui
assistiamo non è altro che una nuova riduzione
rivestita di empatia, che ne è dell’approccio
fenomenologico?
Nonostante l’elemento interattivo, l’intervista è,
infatti, quanto di meno dialettico esista, nel senso
che il suo scopo principale è raccogliere
informazioni, fornire dati per la diagnosi, fornire
informazioni per la cura e la prevenzione, cioè
conoscere l’altro come unilateralità.
Anche quando l’intervista è concepita come approccio
integrato, anche quando il medico adotta un
atteggiamento empatico, comprensivo, attento, il suo
scopo è far emergere dati rilevanti sulla persona e
sui sintomi del paziente. Il protagonista
dell’incontro è sempre e solo lui, perché è lui che fa
le domande e le fa in modo pregiudizievole, orientando
ed indicando la risposta del paziente.
Ma che succede se alla domanda il medico non ottiene
la risposta attesa? L’intervista fallisce, il malato
viene catalogato come strano e la possibilità
di un reale incontro clinico viene negata sul nascere.
Non solo la distinzione tra i due approcci non è
decisiva, ma se, incautamente, il medico si decide
per l’uno piuttosto che per l’altro, continuando a
ragionare per dicotomie e contrapposizioni, incorre in
una serie di situazioni critiche: o, come
abbiamo già visto, identifica i sintomi, ma non
incontra il paziente, o non riesce ad identificare
i sintomi perché le risposte lo depistano, o
identifica i sintomi ma rischia che nell’incontro, a
causa di una eccessiva com-partecipazione, si
comprometta l’oggettività, che pure resta prerogativa
della scienza medica.
Le
perplessità cui mi riferivo non appartengono, dunque,
solo ad una mia riflessione, ma sorgono all’interno di
tali prospettive.
Non sono
pochi gli studiosi che, dopo aver descritto le
caratteristiche positive dell’atteggiamento empatico,
concludono avanzando lo stesso dubbio: e se questo
tipo di empatia non fosse davvero la soluzione? Se la
mancata distinzione tra empatia, compassione e
simpatia non facesse altro che confondere i giovani
medici?
Se il
ponte, che con l’atteggiamento empatico si vuole
gettare, non costituisse altro che una via di fuga
dinanzi ad una situazione che, in qualunque modo la si
affronti, sembra sfuggire di mano? Se
l’identificazione con i propri pazienti nocesse,
anziché fare bene al rapporto?
L’identificazione non pare infatti produrre
quell’apertura che abbiamo detto essere caratteristica
del domandare autentico, ma al contrario provoca una
chiusura, una con-centrazione su se stessi ed un
inglobamento dell’altro; in questa chiusura rimane
inascoltata, perché incompresa nella sua
datità, proprio quella domanda di aiuto che sancisce
il primum dell’atto medico. Probabilmente si
sta allora commettendo di nuovo l’errore che,
paradossalmente, l’approccio integrato voleva
superare: si sta continuando a pensare la relazione
per centrature e si sta sancendo una netta
distinzione tra «dato naturale» e «dato personale» che
in clinica non avrebbe ragione di esistere.
Anche se
l’intervista centrata sul paziente è stata sviluppata
per completare l’intervista centrata sul medico, è,
tuttavia, sconsigliabile usarla separatamente senza
integrarla. Il problema, quindi, non è quale dei due
approcci sia migliore perchè c’è bisogno di ambedue.
A ben
guardare l’intervista testimonia proprio la difficoltà
che il medico incontra nel momento in cui si rende
conto che il metodo oggettivo, ed il modello
biomeccanico che ne consegue, non è sufficiente, ma
non ha la capacità di gestire in modo
personale la relazione e così si illude che una
buona tecnica della comunicazione, basata
sull’empatia, lo possa trarre fuori dall’impaccio. In
realtà tutto si rivela vano perché, al di là di una
immediata impressione che si profila come
soddisfacente, sia medico che paziente avvertono
l’artificiosità della situazione e, anziché
incontrarsi, si distanziano ulteriormente.
Ma dove e
come trovare il trait d’union tra medico e
paziente? Come stare tra oggettività e
compartecipazione?
La strada
per una reale integrazione deve passare, in via
preliminare, attraverso una chiarificazione
terminologica dei termini: empatia, simpatia e
compassione e, parallelamente, attraverso la
crucialità dell’incontro clinico.
Perché
definisco cruciale l’incontro clinico? Per il fatto
che mette faccia a faccia, non uno, ma due
esseri umani che, a partire da una estraneità
irriducibile, lottano per il reciproco
riconoscimento: il medico vuole essere riconosciuto
come tale ed esercita il suo potere, la scienza
e l’arte; il malato vuole essere riconosciuto nel
suo bisogno e, nel momento in cui si reca dal
medico, ha la facoltà di decidere se fare della
propria vulnerabilità uno strumento di potere (dare
fiducia o no, raccontare tutto o nascondere) o di
riconoscimento: accettare l’altro e accettare la
distanza che lo separa dall’altro.
E allora, vista l’ambiguità, che significa provare
empatia? Davvero quando ci sentiamo empatici pensiamo
di essere noi stessi l’essere che
soffre, mettendoci al suo posto? Davvero immaginiamo
le nostre reazioni fuse, in qualche misteriosa
maniera con quelle di chi soffre?
Gli stessi studiosi che avanzano queste teorie non
mancano di avanzare, contemporaneamente, dei dubbi in
merito alla possibilità autentica di assumere in
prima persona l’esperienza di chi ci sta accanto.
È così che, lungi dal risolversi, il problema
dell’empatia si complica ulteriormente.
L’esigenza di fare chiarezza, dimostrando come
l’empatia abbia un che di oggettivo, di cui è invece
mancante la simpatia, è alla base del lavoro di Robert
Katz.
Lo studioso, dopo essersi chiesto se sia davvero
possibile distinguere l’empatia dalla simpatia,
giunge alla conclusione che, nonostante entrambi i
termini si riferiscano a delle situazioni in cui i
sentimenti risultano coinvolti, tuttavia l’empatia
focalizza l’attenzione non sul soggetto senziente, ma
sull’oggetto/soggetto sentito e, quindi, ha un che di
oggettivo.
Quando
empatizziamo, scrive Katz, focalizziamo, infatti, la
nostra attenzione sui sentimenti e sulla situazione di
un’altra persona, mentre quando simpatizziamo
stabiliamo un parallelismo tra i nostri sentimenti e
quelli dell’altro così che non siamo per nulla
concentrati sulla realtà oggettiva e sul carattere
personale della situazione dell’altro. In questo caso
l’analogia prende il posto dell’attenzione e la
comprensione dell’altro, perdendo di oggettività,
risulta compromessa.
L’empatia,
come la simpatia, consiste di sentimenti e implica un
coinvolgimento emotivo, ma a differenza della simpatia
non stabilisce quella similitudine che, generalmente,
porta a chiedersi: che farei io se mi trovassi al suo
posto?
Fino a
questo punto il discorso di Katz potrebbe anche
funzionare: definendo infatti la simpatia come quel
movimento reattivo che fa tornare sul soggetto
stesso che la prova la preoccupazione che in realtà
dovrebbe esser rivolta all’altro soggetto, lo studioso
stabilisce come sia l’empatia, intesa appunto come
attenzione, la base sulla quale costruire autentiche
relazioni di aiuto. Nel momento in cui deve, però,
dare una definizione chiara, da una parte scrive che
quando empatizziamo non possiamo mai interamente
fuggire le nostre necessità - facendoci, quindi,
pensare ad una impossibilità di divenire uno
con l’altro, annullando la distanza e la diversità dei
vissuti, dall’altra, sostiene che durante l’atto
empatico perdiamo completamente la consapevolezza di
noi stessi per annullarci, temporaneamente,
nell’oggetto/soggetto che ci sta di fronte.
La continua contraddizione non fa altro che
disorientarci rendendoci impossibile capire in che
modo funzioni quest’empatia. Ci viene detto che
consiste di attenzione. Ora ad-tensione
significa, etimologicamente, tendere verso, aprirsi ad
un significato.
Allora, come conciliare questo atto originariamente
accogliente, con quello che poi viene detto
dell’empatia, che cioè consista in un entrare
nella mente e nel vissuto altrui perdendo sé stessi?
Viene ribadito come questa perdita sia solo un fatto
temporaneo il cui fine sia quello di andare dentro
per tirare fuori le esperienze altrui. Ma, il
punto è: che significa andare dentro? Come ci si può
annullare per poi riprendersi? Come posso pensare di
vivere con distacco l’immersione
nell’esperienza dell’altro? Immergersi, utilizzando
appieno la metafora, significa, necessariamente,
bagnarsi.
Eppure, a parte gli studiosi che ho citato, sono in
molti a ritenere che le cose stiano così.
Carl Rogers, lo psicoterapista che ha fatto scuola in
merito alle riflessioni sul tema dell’empatia, mette
l’empathic understanding al centro
dell'interesse clinico, considerandola una delle tre
condizioni necessarie e sufficienti per il cambiamento
psicologico. In questi termini l’empatia è pensata
come la capacità di entrare nel mondo personale del
cliente
in modo così intimo da poter capire non solo quello
che egli prova coscientemente, ma anche ciò che si
trova al di sotto della sua consapevolezza, e come la
capacità del terapeuta di comunicare la sua
comprensione dei sentimenti e dei pensieri del
cliente, usando un linguaggio sintonizzato sul suo.
Ma, io mi chiedo, come si può stabilire con il
paziente un simile intimità, come ci si può sentire
a casa con chi sta vivendo, a causa della
malattia, un’esperienza di profondo sradicamento? Se
la malattia, come abbiamo detto, trasforma non solo il
corpo, ma anche il vissuto, se la malattia è ciò che,
per il dis-agio che crea, toglie dal proprio luogo, di
quale casa stiamo parlando?
Credo che i fraintendimenti e l’incapacità di
stabilire cosa l’empatia sia - se un andare dentro, se
una sorta di imitazione, se un coinvolgimento emotivo
e via dicendo - dipendano, in buona parte dal fatto
che la maggior parte degli studiosi fa riferimento a
quella concezione dell’empatia che ci è stata
tramandata da Lipps e che implica un movimento, direi
invasivo, del soggetto nei confronti dell’oggetto,
mentre sconosce l’uso che i fenomenologi
fanno del termine e che, a sua volta, rimanda al senso
greco della parola.
Nell’accezione moderna e contemporanea l’empatia, l’Ein-fühlung,
indica un atto di partecipazione emotiva e
d’immedesimante comprensione nei confronti di un altro
soggetto umano.
Il sentire di cui Lipps parla non ha un’impronta
materialistico-fisiologistica, ma deve essere pensato
come una sorta di imitazione interiore
dell’oggetto, un suo riviverlo interiormente, come è
evidente nella percezione della semplice linea, in cui
mi trovo a ripercorrere in un movimento interiore il
movimento della linea stessa, per sintetizzarlo in
unità. In questi termini tale atto è definibile come
un moto psichico “da…verso”: dalla madre verso il
figlio, dall’amante verso l’amato, da me, un me senza
nome eppure incarnato, verso un altro Io altrettanto
anonimo.
Talvolta questo moto unidirezionale in direzione
dell’altro si converte in una simmetria di affetti: in
un circolo simpatetico.
Giungiamo così ad un altro problema. Che cos’è la
simpatia? Quale il suo rapporto con l’atto empatico?
La
complessità delle argomentazioni è tale per cui non mi
è possibile in questa sede approfondirle
accuratamente, tuttavia ciò che ho notato è che le
analisi di tutti gli studiosi non ci aiutano a capire
come sia possibile partecipare emotivamente al dolore
di un altro senza fondersi con lui.
È come se
mancasse un passaggio essenziale. È come se si fosse
assolutamente certi che ciò di cui l’altro ha bisogno
sia una partecipazione fatta di compenetrazione. E se
non fosse così?
Chi soffre
in prima persona è solito ribadire che nessuno può
capire il suo stato. A tal proposito così scrive
Virginia Woolf:
Della
compassione, per esempio, possiamo farne a meno.
Quell’illusione di un mondo così formato da echeggiare
ogni gemito, di esseri umani così legati da bisogni e
paure comuni che, se tiri il polso di uno, trascini
l’altro, dove, per quanto strane siano le tue
esperienze, anche altri le hanno vissute, dove, per
quanto lontano ti spingi nella tua mente, qualcun
altro c’è stato prima di te - è tutta un’illusione.
Non conosciamo la nostra anima, figuriamoci l’anima
degli altri. Gli esseri umani non procedono mano nella
mano per tutta la strada: C’è una foresta vergine in
ognuno; un campo innevato dove anche l’impronta di un
uccello è sconosciuta. Qui procediamo da soli.
Forse ciò
che non riusciamo a comprendere è che nella domanda di
aiuto non sta la richiesta di una illusoria
immedesimazione, ma l’accorato bisogno di un contatto,
il desiderio di una vicinanza scandita dalla
consapevolezza della incolmabile ed inaggirabile
distanza.
Le indagini che Edith Stein ha dedicato alla
fenomenologia dell’atto empatico possono forse
aiutarci a fare un pò di chiarezza.
Ciò che innanzi tutto preme alla Stein è stabilire una
netta differenza tra un essere umano ed un corpo
fisico. L’altro che io mi trovo di fronte non è
assimilabile ad una bella opera d’arte nella quale mi
trasferisco e nella quale ritrovo una parte di me
stesso. L’altro non corrisponde all’idea che io ho di
lui,
non è una finzione della mente che prende corpo e che,
fichtianamente, l’io decide di opporsi come un non-Io
da superare, ma è un altro in carne ed ossa con
un suo vissuto che mi si presenta immediatamente,
irrompe in me, come una soggettività altra. Io
ho coscienza di questa alterità, mi rendo cioè
immediatamente conto, anche solo guardandolo negli
occhi, che la sua presenza mette in questione
la mia soggettività, la certezza che ho di me,
e la positività “ingenua” del mondo nel quale sono
rinchiuso.
L’io
si pone dunque in rapporto all’altro.
L’altro, in quanto alter-ego, non è
afferrabile con atti mentali, ma con stati emozionali,
è un sentire permeato d’intenzionalità, che favorisce
il trascendimento di me e si apre all’altro così che
possa cogliere i suoi vissuti.
L’altro,
di cui si coglie la differenza con l’io, è il diverso
da me; c’è tra l’io e il tu solo una “condivisione”
del suo dolore e del suo gioire, in altri termini del
suo vivere;
un legame, spiega la Stein,
che non s’identifica mai, né può rendere sostituibile
l’io al tu.
Per far comprendere meglio il paradosso che si
verifica nell’atto empatico la Stein introduce la
distinzione tra originarietà e non
originarietà:
Nel momento in cui io mi rivolgo al dolore dell’altro
non ritrovo qualcosa del mio dolore passato o
semplicemente ricordato, non mi immedesimo nel senso
che vado invasivamente dentro il suo vissuto per
portarlo dentro i miei schemi concettuali, perché
quel vissuto con il quale entro in contatto è
originario ed ha un senso per chi lo prova nell’hic
et nunc della propria realtà di vita, che è, e
resta, anche se comunicata, comunque dell’altro e non
mia. E, allora, perché la Stein dice che quel vissuto,
pur se non originario per me, ha, anche per me,
qualcosa di originario? È, per me, originario
in quanto (come la percezione esterna) si
presenta lì davanti a me ed è quindi qualcosa che,
portandomi comunemente a dire “te lo leggo negli
occhi”, io assimilo al vedere, ma non è originario
in quanto al contenuto perché il dolore visto
non è il mio, ma dell’altro. Viene così
scardinata la logica occidentale secondo cui il vedere
corrisponde al sapere.
In realtà empatia significa allargare la propria
esperienza, renderla capace di accogliere la gioia o
il dolore altrui, mantenendo la distinzione tra me e
l’altro. Può accadere, spesso accade, che in un
secondo tempo avvenga una partecipazione emotiva nella
forma del gioire o del soffrire insieme, ma può
avvenire solo se c’è stata empatia, se l’orizzonte
della mia esperienza si è ampliato, se sono stato
disposto ad uscire fuori dal mio luogo per incontrare
l’altro in un luogo che non corrisponde alla sua
casa - come vuole Rogers - (otterrei così un falso
sapere perché, immedesimandomi, resterei sempre presso
di me) ma che si profila come una terra che non è di
nessuno: la terra della relazione.
Il vissuto empatico presenta sempre un certo grado di
mediatezza, non è un atto in cui immediatamente
cogliamo l’io estraneo e se così ci appare è una
illusione.
L’empatia non va cercata percorrendo l’impossibile
strada della fusione, l’empatia non è un idillio, ma è
un dramma che scatta nel momento in cui due corpi e
due vissuti assolutamente differenti escono
dalla solitudine delle loro monadi mossi dal desiderio
di incontrarsi e comunicare le loro esperienze. È
proprio in questa uscita da sé che il rischio di
confondersi con l’altro o di dominarlo come se fosse
un oggetto diventa altissimo. L’empatia è rendersi
conto dell’ineludibilità di questo rischio e
sorvegliarlo, poiché è solo nel rischio che si dà
autentica relazione.
Mettere in rilievo, contro molte concezioni
dell’empatia come immedesimazione o immediata
partecipazione emotiva, la separazione, anzi la
discontinuità tra me e l’altra, l’altro, vuol dire una
cosa molto importante: prima ancora della
partecipazione, anzi per darle la sua piena verità,
conta entrare in relazione. L’empatia ha tutta
l’intensità del sentire, non è una forma di conoscenza
intellettuale. Il suo valore cognitivo è il rendersi
conto dell’essere in relazione, comprensione - questa
- che significa viversi come non autosufficienti, come
limitati e vulnerabili e, al tempo stesso, come aperti
a qualcosa d’altro.
L’apertura cui la Stein si riferisce è una apertura
intenzionale, non una disposizione del cuore.
Non è l’Io che, pensando, genera l’essere, ma è
l’essere che, ontologicamente, precede e dà contenuto
alla coscienza. La relazione è possibile in quanto
esiste già qualcosa a cui legarci, non è strutturata e
voluta dall’Io. Il passivo precede ontologicamente
l’attivo.
In questa precedenza ontologica il concetto di
vulnerabilità acquista il suo senso autentico. Un
senso che, non riducibile a quello di fragilità o di
precarietà, ci rievoca la struttura originaria della
nostra ex-sistentia, del nostro essere qui ed
ora in virtù di quell’eccedenza, di
quell’esteriorità/estraneità che continuamente ci
pro-voca e che raramente, riconoscendo, accogliamo.
Riconoscere la precedenza ontologica significa
sospendere in se stessi il lavoro dell’immaginazione,
accettare che gli altri con cui entriamo in contatto -
visto che abitiamo un mondo comune - siano diversi
dalle creature della nostra immaginazione. Con questa
accettazione compiamo un movimento interiore opposto
rispetto a quello che facciamo nel momento in cui ci
immedesimiamo - movimento tanto invasivo quanto
espropriante visto che toglie all’altro la possibilità
di assumersi la propria cura - e che non
consiste nello svuotarsi, ma nel fare posto
de-centrandosi.
Ritengo che la differenza sia essenziale: quando
decido di fare posto, io non mi annullo, non mi svuoto
per farmi riempire dall’altro, ma mi contraggo
restando al mio posto.
A questo punto l’empatia assume una rilevanza etica.
Come intendere infatti questo decentramento se non
come disponibilità, e come intendere questa
disponibilità se non come la piena responsabilità
verso l’altro? E responsabilità non è, forse,
autentico aver cura?
L’empatia modifica radicalmente la struttura della
coscienza perché apre alla relazione con altro.
Condividere le emozioni, comprendersi reciprocamente
può essere un’affermazione retorica o un’illusione se
non ha alla base la trasformazione della propria
esperienza prodotta dal tener conto della persona
dell’altro. L’empatia invita a scoprire quanto di solo
apparentemente ovvio e spontaneo c’è in questo “tener
conto della persona dell’altro”. Se non si riduce ad
una funzione cerebrale l’empatia implica infatti una
riorganizzazione di tutte le azioni della nostra vita.
Per
“capire” che cosa prova l’altro dobbiamo effettuare
spostamenti, variazioni di prospettiva e di programmi
per recarci lì dove l’altro è.
Senza la
mediazione dell’esperienza vissuta, senza il fastidio
o l’insofferenza che, talvolta, questo confronto
inevitabilmente porta con sé, queste affermazioni non
significano nulla.
L’empatia non è allora riducibile ad una competenza
tra le altre, non è una tecnica della comunicazione
che funge da captatio benevolentiae, ma è l’essere
a disposizione, il farsi capaci dell’altro
uomo, è quell’a-priori sul quale si fonda la
possibilità stessa di cura.
Il sofferente chiede qualcosa, ma non conosce
perfettamente ciò di cui ha bisogno. Non si tratta
semplicemente di ignoranza sul piano scientifico o di
imperizia tecnica. È tutto il suo mondo precedente che
è stato messo in scacco dall’evento patologico. Egli
abita un mondo nuovo. Ed è lì che ci chiede di andare.
Εμπάθεια significa infatti essere esposto, essere
soggetto a ... Un movimento, dunque, opposto
rispetto a quello di cui abbiamo sino adesso
trattato. Si tratta di un movimento dall’esterno
dell’anima verso il suo interno. L’altro che
irrompe è altro rispetto all’anima; è un
altro non psichico al cui contatto l’anima viene
alterata.
